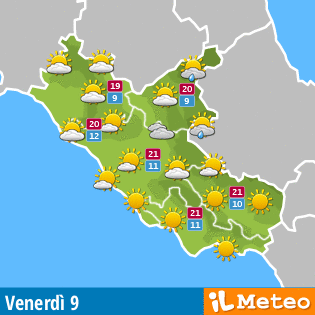ALESSIO ALESSI
Civitavecchia è senza dubbio uno dei “capoluoghi” italiani del pugilato. Una tradizione che si tramanda di padre in figlio. La cittadina tirrenica, grazie alle gesta dei suoi campioni, ha vantato negli anni titoli nazionali ed internazionali ad Olimpiadi, nel dilettantismo e nel professionismo. Un porto non solo di fatto, ma anche metaforicamente, dove hanno approdato molti pugili per allenarsi nella storica palestra di via Borghese. “Figlio adottivo” della scuola civitavecchiese e senza dubbio uno dei migliori prospetti della nostra nobile arte è il peso superpiuma Michael Magnesi. Allenato dal maestro Mario Massai, a soli 25 anni Lonewolf ha già conquistato la corona italiana, quella IBF del Mediterraneo, l’internazionale Silver WBC e l’intercontinentale IBO. Il pugile di Cave è stabile sul primo gradino della graduatoria nazionale, occupa la quarta piazza della classifica europea e il 35esimo posto del ranking mondiale. Insomma, un talento destinato a scalare l’Olimpo della boxe planetaria.
Quando ha conosciuto la nobile arte?
«All’età di cinque anni, papà e mamma sono grandi appassionati. Sono andato a vedere mio fratello che si allenava e gli ho fatto un occhio nero».
A che età ha iniziato a praticare questo sport?
«Ho iniziato a praticarlo a 16 anni, perché prima papà non era troppo favorevole a farmelo fare, consapevole dei sacrifici legati a questa disciplina mi disse: “quando avrai 16 anni deciderai tu cosa fare”.Il giorno stesso in cui sono diventato 16enne ho detto a mio padre che stavo andando in palestra».
Quali sono state le sue prime impressioni?
«È stato un susseguirsi di adrenalina ed emozioni forti. Vedere i ragazzi più grandi allenarsi mi motivava molto. Una passione che cresceva di allenamento in allenamento».
È trascorso molto tempo prima di salire sul ring?
« No, dopo i primi mesi di palestra subito un torneo dilettanti a Pisa, al quale sono seguiti altri impegni».
Questa è una disciplina faticosa, tanti ragazzi dopo il primo approccio mollano. Cosa l’ha spinta ad andare avanti?
«Il sogno che avevo da piccolo: diventare campione del mondo. Non potevo gettare la spugna».
Ci sono stati momenti dove ha pensato di lasciar perdere tutto?
«Sì, ci sono stati. Quando mi hanno letteralmente rubato il primo match da dilettante o a margine di altri verdetti discutibili. L’ultima volta è stata quando si è ammalato mio padre, il quel frangente smisi di allenarmi per qualche mese e pensai anche di smettere, ma dopo ci facemmo una promessa: lui avrebbe continuato a lottare contro il tumore e io avrei continuato ad inseguire il mio sogno mondiale».
Che sacrifici comporta la vita da pugile?
«Tante rinunce. Devi evitare la vita mondana, spesso dimenticandoti anche di essere un ragazzo, o anche una semplice cena fuori quando sei in preparazione e magari devi tagliare il peso. Di riflesso sei costretto a coinvolgere la famiglia nel tuo mondo, quindi hai bisogno di qualcuno pronto a sacrificarsi accanto a te».
Qual è il ricordo più bello della sua carriera da dilettante?
«Quando ho vinto l’ultimo titolo italiano da Youth dopo la malattia di mio padre».
Molti pugili restano a lungo nel dilettantismo, altri passano al professionismo. Scelta volontaria oppure obbligata?
«Se non riesci ad entrare nel giro della Nazionale o di un gruppo sportivo non puoi mai puntare in alto. Chi ci riesce partecipa ad Olimpiadi, Mondiali e altri tornei internazionali e quindi resta più a lungo tra i dilettanti per poi approdare “volontariamente” nel professionismo. Chi non ci riesce, diciamo che è “obbligato” a fare il salto prima. Per quanto mi riguarda il dilettantismo è una strada da battere inizialmente, un percorso di crescita necessario, ma poi si deve passare al professionismo, il vero pugilato secondo me è quello professionistico».
Quanto conta il talento e quanto una spinta dei vertici della federazione per entrare in Nazionale o in un gruppo sportivo?
«In Nazionale o nei gruppi sportivi ci sono sempre le stesse facce e questo potrebbe essere indicativo. Il talento ovviamente conta ma purtroppo volte non basta; devi stare nelle grazie di chi gestisce il sistema pugilato. La spinta sicuramente accorcia i tempi e facilita ad arrivare in alto. A meno che tu sia un talento cristallino che non lascia altra scelta ai tecnici; ma di quelli ne nasce uno ogni cento anni. In definitiva, come in ogni realtà, avere un “santo in Paradiso” aiuta sempre».
Quali sono le differenze principali tra dilettantismo e professionismo?
«Le differenze sono tante. Sono quasi due sport distinti. Nei tre round del dilettantismo devi cercare di prendere pochi colpi e combattere più pulito. Nel professionismo esce la vera essenza del pugile. Anche la preparazione è tutta un’altra cosa, visto che i match sono su una distanza maggiore nei pro; sono tre mesi di allenamento intenso per ogni incontro. In un match internazionale sulla lunga distanza anche un capello fa la differenza».
Qual è stata la prima impressione dopo l’esordio tra i pro?
«Tra l’adrenalina e la voglia di combattere onestamente all’inizio non ci ho capito nulla. Poi è stato bellissimo, perché superato il terzo round mi sono sentito benissimo essendo io un diesel. Mi sono reso conto che il mio pugilato era adatto al professionismo».
Cosa c’è dietro un match? Che tipo di preparazione fa un pugile per arrivare pronto ad una sfida?
«Sicuramente, come ho già accennato, ci sono tanti sacrifici sia fisici che mentali. Rinunce e abnegazione giornaliera. Anche se sei stanco devi andare in palestra e seguire il tuo programma, senza mai mollare; non sono ammesse pause. Per arrivare pronto ad una sfida non puoi tralasciare nulla. Ogni match contempla circa tre mesi di intensa preparazione».
Cosa si prova a vincere un titolo?
«Euforia, è la sensazione più bella che ci possa essere per un pugile».
Anche un guerriero come lei ha paura a volte?
«La paura deve far parte della vita quotidiana di ogni persona, altrimenti il coraggio diventa incoscienza. Un pugile ha paura ma la gestisce. Io non devo scendere dal ring con rimpianti, se vince il mio avversario è perché è più forte di me. Nei momenti difficili non ho paura, cerco solo di dare di più».
Perché la scelta di allenarsi a Civitavecchia.
«Mi alleno a Civitavecchia perché Mario Massai è uno dei migliori maestri in circolazione e sa leggere il match come pochi. Sa vedere i punti deboli del mio avversario. E poi qui a Civitavecchia c’è l’amore della mia vita, mia moglie Alessandra Branco (figlia del campione mondiale Silvio – ndr)».
A 25 anni ha già scalato in modo importante le classifiche mondiali. Qual è l’obiettivo a breve termine e quale quello a lungo raggio?
«A breve termine il Mondiale IBO, che se non ci fosse stato questo Corona virus avrei dovuto disputare a giugno al Foro Italico. A lungo termine il sogno è di avere chance iridate anche in altre sigle».
Un atleta, in Italia, può vivere di solo pugilato?
«Io fortunatamente lo sto facendo, ma è molto dura. Serve un lavoro di pubblicità non indifferente. Il pugile va promosso bene e fortunatamente ho mia moglie che è cresciuta in questo ambiente e mi dà una mano. Un grazie in quest’ottica va soprattutto al mio main sponsor Le Cinéma Café di Roberto Massarone e poi anche al Consorzio Imprese Civitavecchia di Paolo Sbrozzi».
Tanti maestri e palestre di pugilato in Italia, ma pochi iniziano i loro allievi ad una carriera da dilettanti. Spesso molti talenti si perdono per strada. È un problema di tenacia dei giovani, di costi o di professionalità dei maestri?
«Il motivo principale è che un maestro tutela i ragazzi e quindi non tutti i tecnici si sentono di portare gli allievi a combattere. Molti ragazzi vorrebbero affrettare i tempi e lasciano prima».
Attualmente il panorama pugilistico mondiale è dominato dalla figura del peso massimo Tyson Fury, figura carismatica dentro e fuori dal ring. Per avere successo mediatico quanto conta essere un personaggio?
«A differenza dell’Italia, all’estero creano personaggi, facendo conoscere anche la vita privata di queste figure; un modo per far affezionare il pubblico alla persona. Purtroppo qui i manager non spingono sull’immagine del loro assistito».
Secondo lei lo spettacolo fornito da una serie di match ben assortiti dovrebbe essere accompagnato anche dallo show fuori dal quadrato o reputa tutto ciò che gira intorno ad una riunione pugilistica superfluo per il rilancio di questo sport?
«Assolutamente no. Si dovrebbe partire dall’ingresso del pugile. Questo, per esempio, potrebbe essere uno strumento importante di spettacolarizzazione, manca una scenografia della riunione pugilistica che possa legare il pubblico non solo al match, ma prima al personaggio e poi all’evento tutto. Vedo la riunione pugilistica come qualcosa di più del puro sport, dove all’interno, nella giusta misura, dovrebbero esserci anche varie forme d’intrattenimento».
Qual è secondo lei la chiave per rilanciare questo sport?
«Sicuramente rilanciare l’immagine del pugile. Io e mia moglie, anche grazie alla sponsorizzazione di Le Cinéma Café, stiamo facendo un video-documentario sulla mia vita per farmi conoscere meglio. I pugili devono entrare nel cuore del pubblico. Perché dietro ad ogni campione c’è una storia, c’è un uomo con la sua forza e la sua fragilità».
Nonostante tutte le difficoltà della vita di un pugile, perché un ragazzo dovrebbe iniziare a praticare questa disciplina?
«Prima di tutto devi avere la passione, devi ispirarti ai grandi campioni, devi avere un sogno. E poi perché quando realizzi i tuoi obiettivi vieni ripagato di tutti i sacrifici».